
Superbonus e vendita in buona fede: basta per evitare i rischi?
Anche senza intenti speculativi, la cessione di immobili ristrutturati può essere letta dal Fisco come attività d’impresa: ogni caso va valutato con attenzione.
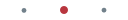
Ho ristrutturato nel 2020 e 2021, sfruttando il Superbonus, un piccolo edificio che avevo ereditato dai miei genitori, ricavando due unità immobiliari che pensavo di destinare ai miei figli. Ora però, a distanza di qualche anno, le cose sono cambiate: mia figlia si sposerà a breve e mio figlio si è trasferito all’estero per motivi di studio. Avrei quindi pensato di vendere la casa, magari nel 2026, dopo che saranno passati cinque anni dai lavori. Ho letto però che ci potrebbero essere dei problemi, ma non riesco a capire se il mio caso vi rientra, considerando che sono pensionato e che ho operato in trasparenza e buona fede. Potreste spiegarmi?
L’esperto risponde
Il dubbio è legittimo e riguarda uno dei terreni più insidiosi connessi al Superbonus: il confine tra la fruizione “lecita” dell’agevolazione da parte di un privato e la possibile riqualificazione, da parte del Fisco, dell’operazione come attività d’impresa. È su questo crinale che si giocano i rischi di revoca del beneficio e le relative conseguenze.
La norma istitutiva, l’art. 119 del DL 34/2020, delimita chiaramente i beneficiari: tra questi figurano le persone fisiche, ma “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni”. È quindi pacifico che le imprese non possano accedere all’agevolazione, se non per lavori sulle parti comuni condominiali. La difficoltà nasce quando il contribuente, pur non essendo formalmente imprenditore, compie operazioni che, per dimensione o finalità, possono essere assimilate a un’attività economica vera e propria.
Sul piano civilistico, l’art. 2082 c.c. definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata. Ma sul piano tributario, l’art. 55 TUIR è molto più ampio: basta l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività economiche rientranti nell’art. 2195 c.c., senza la necessità di una struttura organizzata. In sostanza, per il Fisco non è necessario essere iscritti in Camera di Commercio o avere dipendenti: anche un privato può essere considerato imprenditore se la sua attività è caratterizzata da abitualità o, in certi casi, anche solo da un’operazione unica ma di rilevante entità.
La giurisprudenza e la prassi
In più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha adottato una lettura molto estensiva. Si pensi all’interpello n. 152/2020, in cui un privato aveva ricavato tre unità da un magazzino per poi rivenderle: l’operazione è stata qualificata come imprenditoriale “per la sua rilevanza economica e per la pluralità di atti coordinati” che la componevano. Analogamente, con l’interpello n. 426/2019, l’Agenzia ha ritenuto imprenditoriale l’ampliamento volumetrico effettuato da un privato con l’intento dichiarato di vendere, sottolineando che l’intervento non era destinato a soddisfare un bisogno abitativo ma finalizzato al mercato.
La Cassazione ha più volte ribadito lo stesso principio. Con la sentenza n. 36992 del 16 dicembre 2022 ha chiarito che non è indispensabile l’organizzazione in senso civilistico: anche una singola operazione può integrare attività d’impresa se comporta un rilevante impiego di mezzi economici e un’apprezzabile organizzazione di fattori produttivi. Nel caso esaminato, il contribuente aveva acquistato un edificio, lo aveva frazionato in più unità e le aveva vendute tutte a terzi: circostanza sufficiente, per i giudici, a configurare un’attività economica abituale.
I rischi in caso di contestazione
Qualora l’operazione fosse qualificata come attività d’impresa, le conseguenze sarebbero significative. Da un lato sul piano IVA, con la possibilità che venga richiesto il pagamento dell’imposta sulle vendite anche se già assoggettate a imposta di registro; dall’altro sul piano reddituale, con l’inquadramento della plusvalenza come reddito d’impresa, soggetto a IRPEF e IRAP. Ma la ricaduta più rilevante sarebbe quella sul piano delle agevolazioni fiscali: il Superbonus, non spettando agli imprenditori, potrebbe essere disconosciuto con conseguente recupero del beneficio fruito.
Nessuna regola fissa, valutazione caso per caso
Un punto va sottolineato con chiarezza: non esiste una soglia certa, né quantitativa né temporale, che permetta di distinguere in modo automatico il legittimo utilizzo privato dall’attività d’impresa. L’accertamento è sempre rimesso alla concreta valutazione dell’Agenzia delle Entrate e, in ultima istanza, del giudice tributario. La vendita di un immobile dopo cinque anni dalla ristrutturazione non mette automaticamente al riparo da contestazioni. Ciò che rileva è piuttosto il complesso delle circostanze: la dimensione dei lavori, il numero delle unità ricavate, l’eventuale ricorso a strumenti tipici della commercializzazione e, soprattutto, la destinazione delle unità non alla famiglia ma al mercato.
Alcune cautele utili
Alla luce di questo quadro, l’unico consiglio sensato è la prudenza. Se l’intento originario era davvero familiare, è opportuno che ciò emerga anche nei fatti. Ad esempio, mantenere la proprietà di almeno una delle due unità può contribuire a dimostrare che l’operazione non era interamente speculativa. Ancora meglio, trasferire la residenza o la dimora abituale di un componente del nucleo in una delle unità rende più coerente la narrazione di un intervento destinato ai bisogni personali e non al mercato. Al contrario, la vendita contestuale e integrale di tutte le unità, magari con incarico a un’agenzia immobiliare, potrebbe alimentare la percezione di un’attività imprenditoriale.
Naturalmente, nessuna di queste cautele è di per sé sufficiente a escludere i rischi, ma certamente contribuisce a rafforzare la posizione difensiva in caso di accertamento.
Conclusioni
È vero, quindi, che la vendita di immobili ristrutturati con Superbonus può esporre al rischio di contestazioni e, nei casi più gravi, alla revoca dell’agevolazione. Ma non esiste una regola automatica: ogni situazione va analizzata singolarmente, considerando non solo la tempistica ma soprattutto la finalità e le modalità dell’operazione. Il contribuente prudente non deve temere di pianificare i propri progetti familiari, ma deve essere consapevole che la linea di confine tra legittima gestione del patrimonio e attività d’impresa è sottile, e solo un’attenta valutazione preventiva, mettendo in atto una serie di comportamenti documentabili, può ridurre il rischio di sorprese in sede di controllo.
In definitiva, la prudenza resta la strategia migliore: ogni scelta va calibrata con attenzione, sapendo che, se adeguatamente supportata da fatti e documenti “certi”, anche la buona fede del contribuente può diventare un solido argomento in sede di controllo.

